
Cass.civ. sez. II 4 agosto 2017 n. 19651 rel. Scarpa
Tabelle riscaldamento, nulla la deroga …idiano del Condominio – Il Sole 24 Ore
TabelleRiscaldamentoSentenza19651an
una sentenza estiva di grande rilievo ed interesse
© massimo ginesi 9 agosto 2017
LA SPEZIA – ROMA

Cass.civ. sez. II 4 agosto 2017 n. 19651 rel. Scarpa
Tabelle riscaldamento, nulla la deroga …idiano del Condominio – Il Sole 24 Ore
TabelleRiscaldamentoSentenza19651an
una sentenza estiva di grande rilievo ed interesse
© massimo ginesi 9 agosto 2017

La Cassazione conferma un orientamento consolidato ed espresso dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia 18331/2010.
Un avvocato che aveva assistito il Condominio promuove decreto ingiuntivo per le propri competenze, l’amministratore – senza alcuna delibera sottostante – propone opposizione a detto decreto e l’avvocato eccepisce il difetto di jus postulanti dell’amministratore per non essere stato autorizzato dalla assemblea.
Cass.civ. sez. II 1 agosto 2017 n. 19151 chiarisce che “Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, inaugurato dalla pronuncia delle Ss.UU. 18331/2010, non può ritenersi che l’amministratore del condominio sia titolare di una legittimazione processuale illimitata: l’amministratore può, in via generale, costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma in tale ipotesi, onde evitare una pronuncia di inammissibilità, deve ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte della assemblea stessa.
Si è peraltro precisato che giusto il disposto dell’articolo 1131 commi 2 e 3 cod.civ., autorizzazione e ratifica sono necessarie nelle sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore (cass. 1451/2014), mentre esse non sono necessarie per quelle controversie che hanno ad oggetto parti o servizi condominiali e comunque riconducibili alle attribuzioni di cui all’articolo 1130 c.c. (Cass. 10865/2016).
Da ciò consegue che l’amministratore può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ed altresì impugnare la decisione di primo grado, senza necessità di autorizzazione alla ratifica dell’assemblea, nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento dell’obbligazione assunta dall’amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, in rappresentanza dei partecipanti al condominio, ovvero dando esecuzione a delibere dell’assemblea per l’esercizio dei servizi condominiali, e dunque limiti di cui all’articolo 1130 c.c. (Cass. 16260/2016).
Orbene, nel caso di specie, il credito fatto valere in giudizio si riferiva a prestazioni professionali per l’assistenza legale svolta nell’interesse del condominio, come risulta dallo stesso contenuto del ricorso, in cui gli avvocati ingiungenti hanno evidenziato che l’attività da essi posta in essere è consistita nell’aver curato per conto del condominio diverse procedure giudiziarie.
La causa in oggetto, trovando il suo fondamento nella gestione di servizi comuni e dell’erogazione delle spese relative a tale gestione (art. 1130 commi 2 e 3), si riferisce certamente ad obbligazioni assunte per l’esercizio di servizi condominiali e dunque nei limiti di cui all’articolo 1130 c.c., onde non era necessaria l’autorizzazione, nella successiva ratifica da parte dell’assemblea condominiale.”
© massimo ginesi 3 agosto 2017

Cass.civ. sez. II 26 luglio 2017 n. 18569 affronta un caso peculiare: a causa della ingovernabilità della riunione, l’amministratore – che plausibilmente svolgeva anche funzioni di segretario – ad un certo punto chiude il verbale e si allontana, insieme ad alcuni condomini, portando con sè il libro dei verbali.
I soggetti rimasti, verificato che raggiungono comunque le maggioranze necessarie a deliberare in seconda convocazione, aprono nuovo verbale e deliberano su alcuni punti all’ordine del giorno.
Il Tribunale di Verona aveva considerato valida la delibera successiva, mentre la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto che tale delibera fosse invalida, sull’assunto che essendo stato chiuso il verbale ed essendo diversa la composizione dell’assise, non potesse questa considerarsi mera prosecuzione della prima ma avrebbe richiesto una nuova convocazione, con verifica delle maggioranze necessarie alla costituzione in prima e seconda convocazione.
Osserva il giudice di legittimità, nel rigettare il ricorso che: “Si deve rilevare che la corte di merito, una volta ritenuto che la seduta ulteriore non rappresentasse una mera prosecuzione della precedente, è inevitabilmente pervenuta alla conclusione che la successiva dovesse essere considerata una nuova assemblea e che, per l’effetto, occorresse una nuova convocazione di tutti i condomini (ivi compresi coloro che si erano allontanati) e dovessero essere osservati i quorum costitutivi e deliberativi prescritti per la prima convocazione. Anche in tal guisa la sentenza impugnata non incorre in alcuna violazione dell’articolo 1136 cod.civ. “
© massimo ginesi 31 luglio 2017
Con questa settimana l’attività giudiziale rallenta sino a fermarsi per la pausa feriale prevista per legge dal 1 al 31 agosto, le novità giurisprudenziali da commentare saranno dunque assai poche.
Anche il commentatore coglierà l’occasione per arrampicarsi non solo sui principi del diritto, anche se non mancherà di segnalare gli eventi che meritino attenzione.


Una recentissima sentenza della suprema Corte (Cass.Civ. II sez. 28 luglio 2017 n. 18891 rel. Scarpa) affronta una ipotesi di frequente verificazione nella pratica, riprendendo un consolidato orientamento di legittimità e applicandolo ad una peculiare fattispecie in tema di vizi dell’immobile venduto.
La vicenda attiene alla vendita di un’un Italia immobiliare sita in condominio, dalla cui terrazza a livello derivavano infiltrazioni nei locali sottostanti.
Il compratore si era avvisto di tale circostanza solo dopo che erano trascorsi due anni dall’acquisto, poiché se ne era lamentato il proprietrio dell’unità danneggiata; dalla CTU svolta in primo grado era emerso che “lo stillicidio proveniente dal terrazzo dovesse farsi risalire ad epoca ben anteriore al novembre 2003, visti i tempi occorrenti per l’emersione di un fenomeno di dilavamento”, sicché l’acquirente assume che il vizio gli sia stato dolosamente sottaciuto dai venditori e promuove azione contro costoro.
In primo grado ottiene ragione dal Tribunale di Roma, sull’assunto che non potesse operare nel caso di specie la prescrizione di cui all’art. 1495 cod.civ., avendo i venditori occultato il vizio.
Il secondo grado di merito conduce ad esiti opposti: “La Corte d’Appello osservava come la prescrizione della garanzia dovuta dal venditore, ai sensi dell’art. 1495, comma 3, c.c., si compie “in ogni caso in un anno dalla consegna”, indipendentemente dal tempo della scoperta e dalla valutazione della condotta del venditore, sicchè, avendo le parti stabilito all’art. 6 dell’atto 1 ottobre 2001 che il compratore veniva immediatamente immesso nel possesso dell’immobile, l’azione doveva dirsi prescritta già in data 1 ottobre 2002, mentre la domanda era stata avanzata soltanto il 25 novembre 2004. La Corte di Roma escludeva altresì ogni responsabilità dei venditori ai sensi dell’art. 1669 c.c., in quanto norma disciplinante “esclusivamente la responsabilità dell’appaltatore, qualità non rivestita dalla parte venditrice”.
La vicenda giunge in cassazione ove, con ampia ed interessante disamina che merita integrale lettura, si dichiara l’infondatezza del primo motivo di ricorso, relativo alla applicazione dell’art. 1495 cod.civ. al caso di specie: “Secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte, che viene qui ribadito, in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell’art. 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l’inizio della prescrizione con quest’ultimo evento (Cass. Sez. 2 , 05/05/2017, n. 11037; Cass. Sez. 6 – 2, 15/12/2011, n. 26967; Cass. Sez. 2, 11/09/1991, n. 9510 ; Cass. Sez. 2, 22/07/1991, n. 8169).
Diversamente, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, sempre inerente la garanzia ai sensi dell’art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne abbia acquisito certezza obiettiva e completa (cfr. Cass. Sez. 2, 27/05/2016, n. 11046). Ancora diversamente, in tema di appalto, qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi (Cass Sez. 3, 22/11/2013, n. 26233; Cass. Sez. 3, 19/08/2009, n. 18402).
Agli effetti dell’art. 1495, comma 3, c.c., la consegna è quella, effettiva o materiale, eseguita in forza del contratto di vendita, ovvero attuata contemporaneamente alla conclusione del contratto (come avvenuto nella specie, secondo quanto accertato in fatto di giudici del merito) o in seguito ad essa. Il termine decorre dalla consegna, pertanto, «in ogni caso» (come si esprime la norma in esame), indipendentemente, cioè dal rilievo fattuale che, nonostante l’avvenuta consegna, non fosse ancora possibile la scoperta del vizio da parte del compratore, e quindi anche se il medesimo vizio fosse stato dolosamente occultato dal venditore con espedienti o raggiri, il che rende, piuttosto, non necessaria la denuncia (art. 1495 comma 2, c.c.), giustificandosi tale soluzione alla luce dell’esigenza di evitare che i rapporti negoziali restino per lungo tempo sospesi, ma anche, e soprattutto, di rendere più agevole l’accertamento della sussistenza, della causa e della entità dei vizi (arg. da Cass. Sez. 3, 17/09/1963, n. 2540).
In dottrina si sostiene come, ove il venditore abbia indotto con raggiri il compratore ad acquistare una cosa viziata, ferma comunque la decorrenza della prescrizione dalla consegna del bene, è ammissibile piuttosto, in concorrenza con la garanzia, l’azione di annullamento del contratto per dolo (la cui prescrizione è diversamente regolata dall’art. 1442, comma 2, c.c.), mentre è pure possibile invocare la sospensione della prescrizione dell’azione di garanzia fin quando il compratore non abbia scoperto i vizi, ma ciò in base all’art. 2941, n. 8, c.c., secondo il quale la prescrizione resta, appunto, sospesa ove il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, e fino alla scoperta di esso.
A tal fine, questa Corte ha già affermato che, per la sospensione della prescrizione dell’azione di garanzia accordata al compratore, agli effetti dell’art. 2941, n. 8, c.c., occorre accertare la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero, quanto altresì caratterizzata da consapevolezza dell’esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente (Cass. Sez. 2, 20/08/2013, n. 19240). Le questioni poste dall’art. 1442, comma 2, c.c. e dall’art. 2941, n. 8, c.c., sono tuttavia, diverse da quelle cui fa specifico riferimento il primo motivo di ricorso, che indica, quale norma regolatrice della fattispecie, unicamente l’art. 1495, comma 3, c.c., e critica perciò la soluzione adottata dalla Corte d’appello di Roma mediante argomentazioni intese a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata siano in contrasto esclusivamente con tale norma.”
E’ invece accolta la tesi sulla applicabilità al caso di specie, della garanzia ex art. 1669 cod.civ. che trova applicazione – secondo una recente pronuncia delle sezioni unite – anche in caso di ristrutturazione e che fa pertanto assumere al venditore – che abbia proceduto a lavori qualificanti sul bene – la posizione di garanzia dell’appaltatore: “La Corte d’appello di Roma ha negato ogni responsabilità dei venditori pure ai sensi dell’art. 1669 c.c., in quanto norma ritenuta disciplinante “esclusivamente la responsabilità dell’appaltatore, qualità non rivestita dalla parte venditrice.
La decisione di tale questione di diritto adotatta dai giudici d’appello contrasta con l’interpretazione più volte ribadita da questa Corte, per la quale l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 c.c., nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, può essere esercitata, in ragione della sua natura extracontrattuale, non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera, ed abbia perciò esercitato un potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, tale da rendergli addebitabile l’evento dannoso (così Cass. Sez. 2, 17/04/2013, n. 9370; Cass. Sez. 2, 16/02/2012, n. 2238; Cass. Sez. 2, 29/03/2002, n. 4622).
La responsabilità del venditore, in ordine alla conseguenze dannose dei gravi difetti di costruzione incidenti profondamente sugli elementi essenziali dell’opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione, è configurabile sia quanto questi abbia costruito l’immobile e lo abbia poi alienato all’acquirente, sia quando il medesimo venditore abbia incaricato un terzo appaltatore della costruzione del bene prima della sua vendita (arg. da Cass. Sez. 2, 16/02/2006, n. 3406).
Di recente, Cass. Sez. U, 27/03/2017, n. 7756, componendo il contrasto di pronunce esistente sul punto, ha stabilito che l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
Risulta, nel caso in esame, accertato in fatto che i venditori B – L, alcuni anni prima di alienare ad E.F. l’appartamento sito in Roma, via P 11, avessero dato incarico da un’impresa appaltatrice di eseguire lavori di totale rifacimento della pavimentazione e dell’impermeabilizzazione del terrazzo.
Deve pertanto essere enunciato il seguente prinicpio di diritto: “L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, di cui all’art. 1669 c.c.c, può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull’immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti”
© massimo ginesi 29 luglio 2017
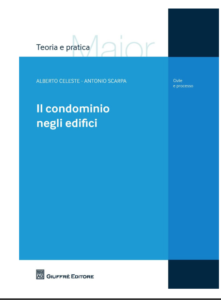
negli ultimi quattro mesi, in cui per ragioni professionali e scientifiche mi è capitato di consultare buona parte della letteratura in tema di condominio, ho trovato nel testo a firma di Alberto Celeste e Antonio Scarpa, edito nel 2017 da Giuffrè, uno strumento straordinario, ricchissimo di spunti, con una sterminata rassegna giurisprudenziale e un approfondimento dei temi – anche più recenti, conseguenti alle modifiche introdotte dalla L. 220/2012 – che ben riflette la levatura dei due studiosi (entrambi alti magistrati), di prim’ordine nel panorama scientifico giuridico .
Un testo che non ci si stanca di consultare, di approfondire e di ripercorrere, in cui gli argomenti sono trattati separatamente dai due autori (ciascuno ne svolge alcuni integralmente) evidenziando le caratteristiche espositive e speculative di ciascuno, che contribuiscono ad una lettura completa e originale della materia.
Un “must to have”.
© massimo ginesi 27 luglio 2017

L’installazione di una telecamera da parte di un singolo condomino all’esterno della propria unità, che riprenda il pianerottolo e parte delle scale, non costituisce condotta a rilevanza penale.
In particolare, secondo la Cassazione ( Cass.pen. sez. V 12 luglio 2017, n. 34151) tale condotta non integra gli estremi dell’art. 615 bis cod.pen. che punisce le interferenze illecite nella vita privata.
i fatti avevano portato alla condanna dell’imputato in primo grado, poi assolto in appello: “Ti. Ro. – condomino di uno stabile condiviso con i coniugi Al./Bi. – era stato condannato dalTribunale di Palermo per il reato di cui all’art. 615/bis cod. pen. per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, nella parte contigua alla porta d’ingresso della propria abitazione, con cui inquadrava la porzione di pianerottolo prospiciente la porta suddetta, nonché “la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale”, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d’azione della telecamera. Secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, la telecamera inquadrava anche la porta d’ingresso dei coniugi Al.-Bi., prospiciente quella dell’imputato, allorché era chiusa l’anta della finestra che illuminava il pianerottolo condominiale: anta che, proprio per evitare l’indebita interferenza, i coniugi Al.-Bi. cercavano di tenere sempre aperta.
La Corte d’appello di Palermo – andando di contrario avviso rispetto al giudice di prima cura – ha assolto Ti. per insussistenza del fatto. Ad avviso del giudice di secondo grado, il pianerottolocondominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all’art. 614 cod. pen. (richiamato dall’art. 615/bis cod. pen.), e la telecamera di cui si discute – puntata sulla rampa di scale poste accanto alla porta d’ingresso dell’imputato – “aveva un raggio di ripresa che evidentemente interessava soltanto l’uscio di casa del Ti. e solo parte del pianerottolo”, tant’è che neppure la rampa di scale che porta al piano superiore era completamente ripresa.”
LA cassazione ha confermato la lettura di secondo grado, rilevando che pianerottolo e parti comuni non possono, in genere, essere ritenuti luoghi di privata dimora: “L’art. 615/bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen.; vale a dire, nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle “appartenenze” di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.
Peraltro, proprio l’oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio.
Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (si vedano: Cass. 10-11-06 n. 5591, Rv. 236120, la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del “pianerottolo” di un’abitazione privata, oltre che dell’area antistante l’ingresso di un garage condominiale; Cass., n. 37530 del 25-10-06, Rv. 235027, con riguardo alle videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale; Cass., n. 44701 del 29/10/2008, Rv. 242588, ancora una volta con riguardo alle riprese di un’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso).”
Il fatto che tale condotta non costituisca reato, non significa che sotto il profilo civile l’installazione possa risultare comunque illecita, atteso che sia il garante della privacy (provv. 8.4.2010) che la Cassazione (Cass. 26.11.2008 n. 44156) hanno ritenuto illecita la telecamera installata dal singolo il cui angolo di ripresa non sia limitato unicamente alla sua proprietà esclusiva (ad esempio il portone di ingresso9).
© massimo ginesi 27 luglio 2017
.

il 22 giugno 2017 è stata presentata proposta di legge n. 4560, con cui si intende modificare due profili introdotti dalla legge 220/2012 nella disciplina condominiale, ovvero il divieto di conferire delega all’amministratore e la responsabilità solidale dell’acquirente di unità immobiliare per le quote relative all’esercizio in corso e a quello precedente prevista dall’art. 63 disp.att. cod.civ.
L’abrogazione dell’inciso dell’art. 67 disp.att. cod.civ. è sicuramente auspicabile, atteso che il conferimento di delega all’amministratore – lungi dal rappresentare un momento di conflitto di interesse – è stato per decenni uno strumento risolutivo per una efficace celebrazione delle assemblee.
Più curioso il concetto di “condomino acquirente”, utilizzato dal latore della proposta, che vorrebbe obbligare chi acquista per i contributi maturati nei cinque anni antecedenti la vendita.
Non sfuggirà che condomino è colui che sia titolare di un diritto reale all’interno della compagine condominiale, dunque il condomino acquirente è un sorta di creatura mitologica che non può esistere.
Il testo del DDL è il seguente: “Chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi già maturati fino al quinquennio antecedente al trasferimento. L’amministratore deve fornire anche al condòmino acquirente, che ne faccia richiesta, quanto previsto dall’articolo 10 punto 9 della legge 11 dicembre 2012 n° 220. Tale attestazione va allegata al contratto che determina il trasferimento del diritto di proprietà su unità immobiliari”.
La relazione accompagnatoria promette – con l’introduzione di tale modifica – una drastica diminuzione delle liti.
Restano tuttavia insolute due questioni fondamentali: l’acquirente (che non è ancora, evidentemente, condomino) potrebbe dimostrare tale sua qualità all’amministratore – onde richiedere l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti – solo tramite un contratto preliminare che già lo obbligherebbe all’acquisto, senza che l’eventuale attestazione possa a quel punto costituire motivo di risoluzione del vincolo obbligatorio.
In diversa ipotesi si consentirebbe a chiunque si affermasse promissario acquirente, di ottenere informazioni sul condominio e sui morosi, ovvero dati non divulgabili a soggetti diversi da quelli previsti dall’art. 1130 n. 9 cod.civ.
E’ evidente che il senso della modifica si avrebbe solo ove si consentisse, a colui che intende acquistare, di calibrare le obbligazioni con il venditore sulla scorta anche degli oneri condominiali insoluti e ciò prima di divenire, tecnicamente, un “promissario acquirente”, ovvero prima di stipulare alcun vincolo.
Si potrebbe ipotizzare che il promissario acquirente ottenga tali dati con il consenso del condomino venditore, ma in tal caso non occorre alcuna modifica alla legge, atteso che – ovviamente – il condomino ha titolo a conoscere lo stato dei pagamenti e potrà poi divulgarlo a chi ritiene più opportuno, sotto la propria responsabilità.
Curioso anche l’obbligo di allegazione all’atto di acquisto della attestazione che otterrebbe il fantomatico “condomino acquirente”: con la sottoscrizione dell’atto e la prestazione del consenso le parti danno comunque luogo all’effetto traslativo, pur in assenza della ipotetica attestazione; in assenza di alcuna specifica conseguenza prevista dalla norma per la mancata allegazione, l’inadempimento – non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 1477 cod.civ. o 1490 cod.civ. – sembrerebbe lasciare aperta l’unica via risarcitoria (pur con qualche dubbio, visto che comunque l’acquirente si determina ad acquistare pure in sua assenza), soluzione che appare destinata ad innalzare il contenzioso più che a sopirlo.
© massimo ginesi 25 luglio 2017

La suprema Corte ribadisce un principio consolidato riguardo alla classica fattispecie in cui alcuni condomini affermano la proprietà esclusiva del cortile ed altri ne sostengono invece la condominialità.
Cass.Civ. II sez. 14 giugno 2017 . n 14809 riafferma il principio che : “la presunzione stabilita per i beni elencati nell’articolo 1117 c.c., la cui elencazione non e’ tassativa, deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune (Cass. Civ. sent. del 23/08/2007 n.17928) e colui che rivendica la proprieta’ esclusiva deve superare tale presunzione fornendo la prova di tale diritto, producendo un titolo d’acquisto da cui risulta escluso il bene dalla comunione. A tal fine, titolo d’acquisto deve ritenersi, come gia’ evidenziato, l’atto costitutivo del condominio, che si identifica col primo atto di trasferimento di una unita’ immobiliare del fabbricato dall’originario ad altro soggetto (Cass. Civ. Sez. 2 sent del 27/05/2011 n. 11812).
“Giova precisare che quella prevista dall’articolo 1117 c.c. non costituisce una presunzione in senso tecnico ma, piuttosto, l’attribuzione legale della natura comune ai beni elencati in tale norma. Attribuzione, questa, che puo’ essere derogata solo con patto contrario, risultante dall’atto costitutivo del condominio o con usucapione. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprieta’ di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni comuni (nella specie, portico e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni.”
Assai curioso che coloro che si affermavano proprietari del cortile prendessero di dimostrare il loro titolo attraverso l’atto di acquisto dell’originario appezzamento di terreno su cui è stato costruito il condominio: “la Corte d’Appello, ha correttamente escluso che i documenti prodotti in appello dall’odierno ricorrente avessero una rilevanza probatoria, in quanto l’atto di vendita ( (OMISSIS) – (OMISSIS)) dell’intero appezzamento di terreno del 10.1.1928 evidentemente nulla provava in ordine alla proprieta’ esclusiva del cortile condominiale, come nessun rilievo poteva avere la mappa della zona, tra l’altro riferibile al periodo 2001-2008, ne’ le note di trascrizione intervenute nei confronti di soggetti diversi rispetto alle parti in causa”.
© massimo ginesi 21 luglio 2017
