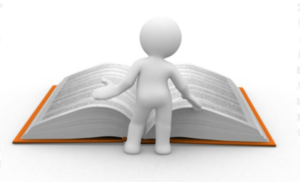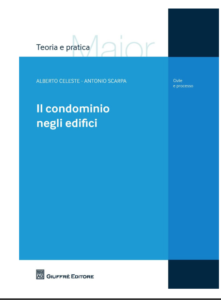La Suprema Corte ripercorre i principi cardine delle servitù, avuto riguardo a controversia sorta in ambito condominiale (Cass.civ. sez. II ord. 31 agosto 2017 n. 20614 rel. Scarpa).
La causa ha ad oggetto un diritto di servitù di passo, vantato da una condomina sul terrazzo di un altro condomino, domanda peraltro disattesa sia in primo che in secondo grado: “Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 18 febbraio 1993 formulata da R. M., la quale convenne davanti al Tribunale di Roma F.F., chiedendone la condanna alla riduzione in pristino ed al risarcimento dei danni correlati ai lavori di modificazione del terrazzo di proprietà F, compreso nel Condominio di via V. 18, Roma, in quanto gravato, a dire dell’attrice, da servitù di passaggio a vantaggio del terrazzo annesso all’appartamento di proprietà M.”
La Cassazione – nel respingere anche in sede di legittimità la domanda – ripercorre alcuni passaggi essenziali in tema di diritti reali e di servitù in particolare:
a) incombe a colui che agisce per vedere riconosciuto un diritto reale fornire la prova di essere titolare di quel diritto: “la Corte d’Appello ha proceduto all’interpretazione della domanda di R. M., e ciò nell’esercizio di prerogativa che spetta al giudice del merito, ed ha evidentemente qualificato l’azione come una “confessoria servitutis”, ai sensi dell’art. 1079 c.c. Incombeva pertanto certamente sull’attrice l’onere di provare l’esistenza del relativo diritto di passaggio sul limitrofo terrazzo di proprietà F, ovvero la costituzione della servitù per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (cfr. Cass. Sez. 2, 11/01/2017, n. 472; Cass. Sez. 2, 08/09/2014, n. 18890).”
Se l’attrice avesse ritenuto (ma ciò non appare, invero, nemmeno specificamente allegato in sede di ricorso) che la costituzione della vantata servitù di passaggio fosse avvenuta per destinazione del padre di famiglia, allora le sarebbe spettato di fornire prova di opere visibili e permanenti realizzate al preciso scopo di dare accesso al preteso fondo dominante attribuito a A. M. A. P. (dante causa di F. C., a sua volte dante causa di R. M.) attraverso quello preteso servente attribuito a V. A. P. (dante causa di F. F.), opere predisposte dall’unica proprietaria B. P., e preesistenti al momento il cui il fabbricato di via Venezia 18 venne diviso fra più proprietari con l’atto pubblico del 20 gennaio 1942 (cfr. Sez. 2, Cass. 05/04/2016, n. 6592). Altrimenti, ove la servitù posta dalla ricorrente a base della sua azione confessoria fosse stata fondata su un contratto, le occorreva, stante l’esigenza di forma ad substantiam posta dall’art. 1350, n. 4, c.c., di dar prova di un atto scritto che consacrasse la esplicita manifestazione di volontà negoziale di costituire, a favore della proprietà di A. M. A. P. (ovvero di F. C., ovvero ancora della stessa R. M.) una servitù di passaggio convenzionale sul terrazzo di proprietà di V. A. P. (ovvero di F.F.).
b) il titolo non trascritto non è opponibile agli acquirenti successivi, salvo che gli stessi non abbiano riconosciuto l’esistenza del diritto nell’atto di acquisto: “Ove si trattasse di un contratto di costituzione della servitù comunque non trascritto (come quello del 15 aprile 1972), esso non sarebbe stato opponibile a chi, come il F., abbia acquistato il proprio appartamento come libero ed abbia trascritto il proprio titolo; a meno che il terzo, acquirente a titolo particolare dell’immobile interessato da servitù di passaggio in base a titolo non trascritto, non avesse, all’atto dell’acquisto, dichiarato di essere a conoscenza dell’atto costitutivo della servitù e manifestato la volontà di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dalla relativa scrittura (Cass. Sez. 2, 07/01/1978, n. 46).
c) le dichiarazioni unilaterali, seppur formali, del titolare del fondo dominante non hanno alcun rilievo ai fini della costituzione (o del riconoscimento) del diritto: “Né può ovviamente valere a dire costituita la servitù la dichiarazione unilaterale della donante A.M. A. P., contenuta nell’atto di donazione del 15 gennaio 1981, quanto all’esistenza dell’ “accesso da terrazzo di proprietà di F. F.”; essa dà luogo ad un’irrilevante ricognizione della servitù proveniente dalla proprietaria del fondo dominante, del tutto priva di una funzione sostanziale idonea a supplire alla mancanza genetica del titolo costitutivo della servitù stessa, da porre a carico del fondo di un terzo non partecipe al contratto”.
© massimo ginesi 4 settembre 2017