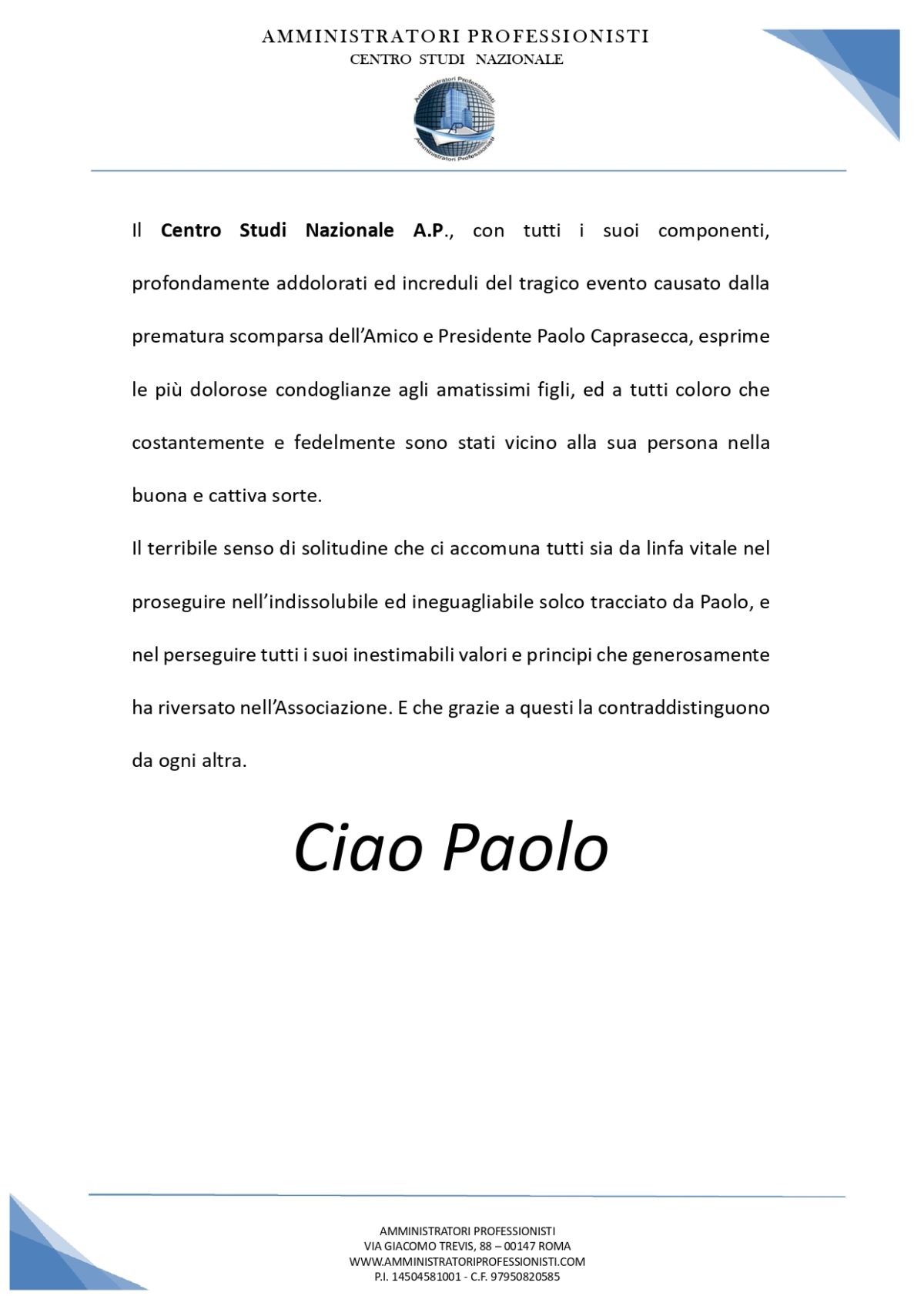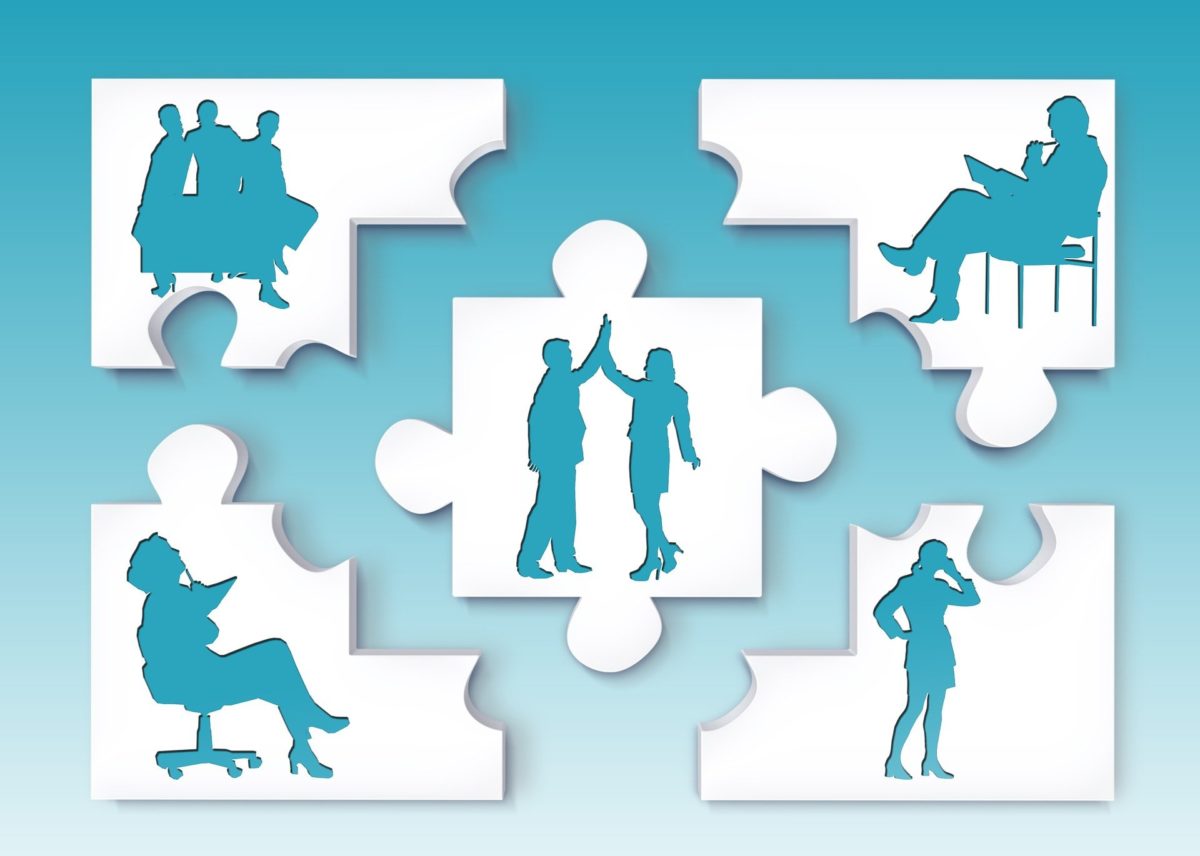La Suprema Corte (Cass.civ. sez. II ord. 4.2.2021 n. 2635 rel. Scarpa) ripercorre l’orientamento interpretativo maturato anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 69 disp.att. cod.civ., così come novellato nel 2012.
In forza di principio di diritto affermato dalle sezioni unite del 2010, la tabella millesimale che rispecchi i valori proporzionali delle singole unità e non deroghi in via contrattuale ai criteri previsti dall’art. 1123 c.c. può essere approvata a maggioranza; la sua impugnativa non comporta litisconsorzio necessario dei singoli condomini ma vede legittimato passivo unicamente l’amministratore.
La pronuncia giudiziale di revisione ha valenza ex nunc e, dunque, non avendo portata retroattiva, comporta che le delibere precedentemente adottate sula scorta delle tabelle oggetto di revisione mantengano piena validità.
“Non può trovare applicazione nel presente giudizio, che attiene a domanda di revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale proposta con citazione del 19 maggio 2004, l’art. 69 disp. att. c.c., comma 2 nella riformulazione conseguente alla L. 11 dicembre 2012, n. 220.
Non di meno, la sostanziale fondatezza del primo motivo di ricorso e l’erroneità della decisione della relativa questione di diritto operata dalla Corte d’appello di Cagliari (nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto derivare dalla riqualificazione della domanda attorea come revisione delle tabelle la necessità del litisconsorzio) discendono alla stregua dell’interpretazione offerta da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477.
Tale sentenza chiarì come l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, purchè tale approvazione sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell’esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell’uso.
I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall’art. 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, mediante convenzione, la quale può essere contenuta o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce “di natura contrattuale”), o in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità.
Viene, quindi, imposta, a pena di radicale nullità l’approvazione di tutti i condomini per le sole delibere dell’assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall’art. 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento “contrattuale” (Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126). Rivela dunque natura contrattuale soltanto la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all’art. 1123 c.c., comma 1. Se, invece, sia stata approvata una tabella meramente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali, e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza dell’art. 1136 c.c., comma 2, per ripristinarne la correttezza aritmetica (Cass. Sez. 6 – 2, 25/01/2018, n. 1848; Cass. Sez. 2, 25/10/2018, n. 27159).
La giurisprudenza ha anche tratto le dovute conseguenze di ordine processuale dall’insegnamento di Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477.
Una volta affermato il fondamento assembleare, e non unanimistico, dell’approvazione delle tabelle, alcuna limitazione può sussistere in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell’amministratore per qualsiasi azione, ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 2, volta alla determinazione giudiziale o alla revisione di una tabella millesimale che consenta la distribuzione proporzionale delle spese in applicazione aritmetica dei criteri legali (tale risultando, nella specie, la domanda proposta da P.L., la quale assume l’erroneità delle tabelle millesimali vigenti in relazione ai valori proporzionali della sua unità immobiliare e di quelle di M.M.M. e di Mo.Al.).
Si tratta, infatti, di controversia rientrante tra le attribuzioni dell’amministratore stabilite dall’art. 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali dello stesso, senza alcuna necessità del litisconsorzio di tutti i condomini. Riconosciuta, nella sostanza, la competenza gestoria dell’assemblea in ordine all’approvazione ed alla revisione delle tabelle millesimali, non vi può essere resistenza a ravvisare in materia altresì la rappresentanza giudiziale dell’amministratore (come del resto desumibile poi dal già richiamato art. 69, disp. att. c.c., comma 2 nella riformulazione conseguente alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, nella specie non applicabile ratione temporis) (Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).
…secondo l’orientamento di questa Corte, la portata non retroattiva della pronuncia di formazione o di revisione giudiziale delle tabelle millesimali comporta che non possa affatto affermarsi l’invalidità (o addirittura l’illiceità fonte di danno ex art. 2043 c.c., come ipotizza la ricorrente) di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore, il che provocherebbe, altrimenti, pretese restitutorie correlate alle ripartizioni delle spese medio tempore operate, in applicazione della cosiddetta “teoria del saldo” (Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735; Cass. Sez. 2, 24/02/2017, n. 4844; Cass. Sez. 3, 10/03/2011, n. 5690; Cass. Sez. U, 30/07/2007, n. 16794).”
© massimo ginesi 24 febbraio 2021