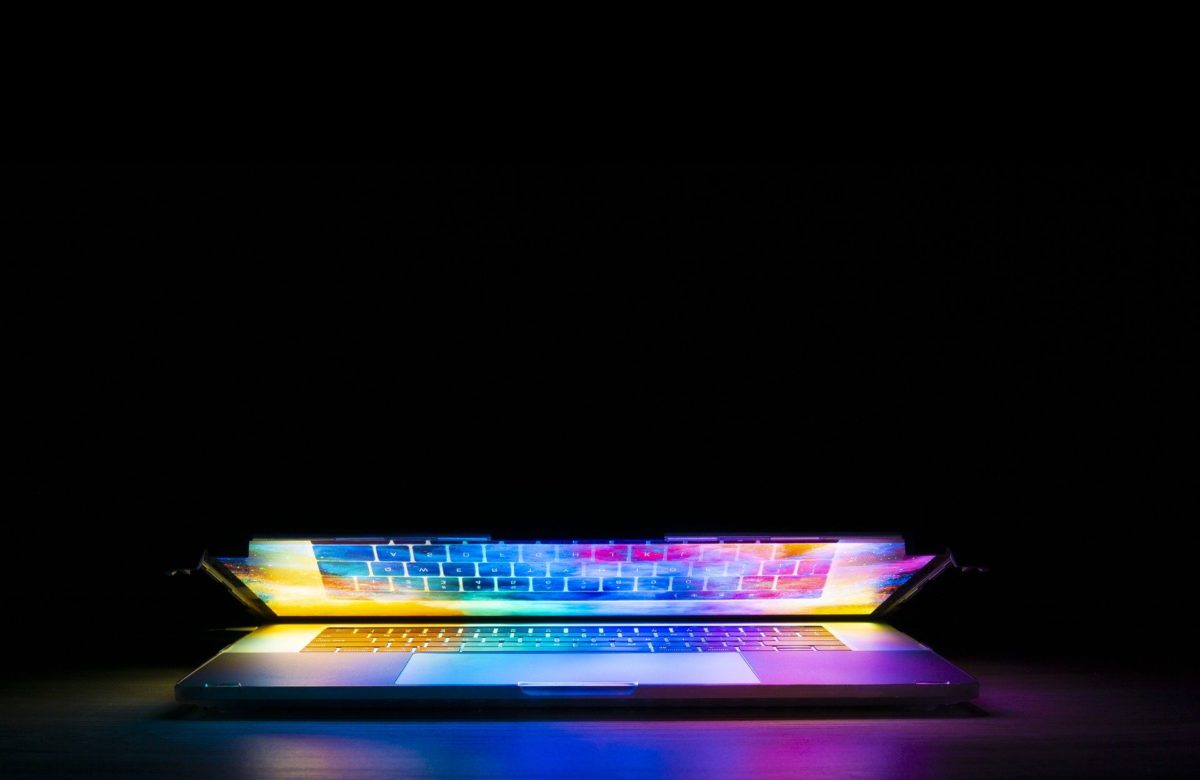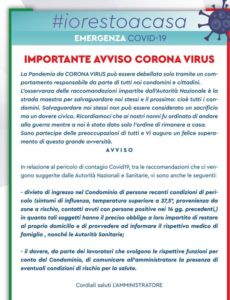
in questi tempi virali si legge un pò di tutto sul web, poiché pare che il timore di contagio abbia ormai dato via libera al bar virtuale, lucidamente preconizzato da Umberto Eco agli albori di internet.
A fronte di un quadro “normativo” semplicemente folle, che negli ultimi mesi ha visto stratificarsi DPCM, decreti legge convertiti con modifiche, decreti ministeriali, ordinanze, circolari e chi più ne ha più ne metta, non è facile districarsi fra le condotte lecite e quelle che invece incombono ex lege a determinati soggetti.
Certamente l’amministratore di condominio, cui è demandata una posizione di garanzia nei limiti di cui all’art. 1130 c.c., si trova ad affrontare un periodo non semplice
Fra le sortite più gustose viste sul web appare questo avviso, con il quale una delle tante associazioni di settore sembra invitare a trasmettere l’avviso ai propri amministrati, ai quali si ricorda il divieto di ingresso nel condominio per coloro che abbiano la febbre oppure manifestino sintomi influenzali.
All’amministratore che invita i propri condomini al rispetto delle norme di prudenza sconsiglieremmo di enfatizzare il messaggio ricordando loro che – non essendo coscritti su qualche tradotta diretta al Carso – tutto il resto dovrebbe apparire una sorta di attività ricreativa piacevole. Non tutti potrebbero gradire richiami così forti (e incongrui) e, alla prossima nomina, qualche condominio un pò più progressista potrebbe guardarsi intorno…
Nel merito sarebbe curioso comprendere come questi solerti tutori della salute pubblica intendano attuare il consiglio: forse chiedendo una autocertificazione al malcapitato sulla propria temperatura, i propri contatti, i propri viaggi (atto che questo signore non è affatto tenuto a rilasciare ad un privato), oppure mettendo una guardia armata al posto del portiere che sottoponga l’ospite al termoscanner (escluderemmo prelievi coattivi con termometri tradizionali…) e poi gli sbarri il passo, ma – soprattutto – quali poteri avrebbero l’amministratore, il portiere o un condomino di impedire fisicamente l’accesso di chicchessia al condominio (che sia condomino o privato che si rechi da un condomino)?
Forse è entrata in vigore qualche legge speciale che istituisce il podestà di condominio e che ci è sfuggita?
a noi pareva di ricordare che il DPCM 10 aprile 2020, che dispone proroga delle misure di contenimento e distanziamento sino al 3 maggio p.v., all’art. 1 preveda
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
Anche a non voler rilevare che “fortemente raccomandato” è termine che già solo sotto il profilo sintattico e grammaticale differisce da “è fatto obbligo”, si tratta, in ogni caso, di misure che non consentono di inibire l’accesso ad alcuno ma, semmai, di attivarsi presso la pubblica autorità per segnalare la violazione.
Costoro hanno poi ritenuto di trasformare la raccomandazione in divieto di accesso, da far rispettare da parte di soggetti sforniti di qualunque qualifica pubblica, che dovrebbero impedire l’ingresso al condominio di qualcuno febbricitante (perché magari ha un ascesso a un dente…), iniziativa del tutto arbitraria nei conforti di un condomino che magari in quel fabbricato possiede un domicilio ove, per semplici ragioni logistiche, intende trascorrere qualche tempo in questo complesso periodo.
Tecnicamente potrebbe chiamarsi violenza privata, prevista e punita dall’art. 610 cod.pen.
Mala tempora currunt: paura e disinformazione sono i virus dell’anima e delle idee, attenzione.
© massimo ginesi 17 aprile 2020
Foto di LEEROY Agency da Pixabay