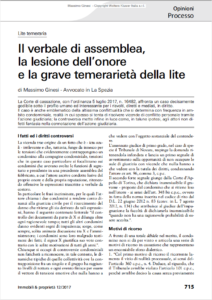Un amministratore non rende il conto della propria gestione per più esercizi consecutivi, alcuni condomini ricorrono al giudice chiedendo la revoca dell’amministratore inadempiente e – nel frattempo – costui presenta i bilanci, che l’assemblea del condominio approva.
La corte di legittimità (Cass.civ. sez. II 30 novembre 2017 n. 28764) pur rilevando l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di secondo grado, ripercorre la decisione del giudice di merito che ha ritenuto che l’avvenuta tardiva approvazione non incide comunque sulle ragioni che giustificano la revoca, pronunciata in quel caso dal Tribunale di Napoli e confermata in sede di reclamo, dalla Corte d’Appello partenopea.
La pronuncia – seppure con richiamo alla decisione di merito – contiene un interessante escursus sui doveri dell’amministratore in tema di rendiconto, sia con riferimento alla disciplina antecedente la riforma del 2012, sia alla luce della normativa vigente ed affronta anche il problema del divieto – previsto dall’attuale art. 1129 cod.civ. – di nominare nuovamente l’amministratore revocato giudizialmente.
Osserva la Corte di Cassazione che “La corte di appello di Napoli ha ritenuto, per un verso, che le delibere adottate dall’assemblea condominiale in pendenza del procedimento (vale a dire l’approvazione dei rendiconti 2010, 2011, 2012 e 2013 e la sua conferma nella carica di amministratore del condominio) non abbiano eliso l’interesse del P. alla richiesta pronuncia di revoca (“la circostanza che … l’amministratore abbia presentato i rendiconti 2010, 2011 2012 e 2013 e che l’assemblea li abbia approvati non vale … a sanare l’inadempimento: i rendiconti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati presentati con notevole ritardo … sicché non può dubitarsi che l’amministratore ha violato uno dei suoi obblighi primari, che è quello di rendere il conto della sua gestione “alla fine di ciascun anno” (secondo l’originaria formulazione dell’art. 1130 ult. co . c.c) ovvero, secondo il nuovo dettato dell’art. 1130 ult. co . c.c., di redigere il rendiconto condominiale “annuale” della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”;
né – ha aggiunto la corte – può rilevare la conferma dell’avv. V. M. nella carica di amministratore del condominio, decisa dall’assemblea con delibera del 10/3/2014, posto che, a norma dell’art. 1129, comma 13°, c.c., nel testo successivo alla riforma di cui alla I. n. 220 del 2012, “in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato”, “sicché, diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, l’assemblea non è libera di nominare nuovamente l’amministratore resosi inadempiente e revocato con provvedimento dell’autorità giudiziaria”: il reclamato, quindi, ha concluso la corte, “ha uno specifico interesse ad ottenere il provvedimento giudiziale di revoca perché potrebbe far valere l’illegittimità della nomina dell’avv. V. M., impugnando la relativa delibera”) e, per altro verso, che le giustificazione addotte dalla reclamante (e cioè che il P., con la sua attività ostruzionistica e defatigante, avrebbe contribuito a ritardare la presentazione dei rendiconti) sono risultate generiche e, soprattutto, non hanno consentito “di evincere il nesso causale tra la condotta del reclamato ed il ritardo nella presentazione dei rendiconti”.
Quanto alle censure mosse nel ricorso per cassazione, la Corte rileva che: ” il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo nei confronti del decreto del tribunale di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c., anche nel testo successivo alla riforma di cui alla I. n. 220 del 2012, non è, infatti, ammissibile. Si tratta, in effetti, di un provvedimento camerale che, pur se reso all’esito di un procedimento plurilaterale, e cioè ad interessi contrapposti, non ha alcuna efficacia decisoria, lasciando all’amministratore revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso e di far valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (Cass. n. 15706/2017, in motiv.).”
Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. è, infatti, ammissibile (soltanto) avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e di credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Il motivo è, tuttavia, infondato. La conferma da parte della corte d’appello del decreto del tribunale in materia di spese di lite è conforme all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (Cass. n. 1775/2017). Nel caso di specie, la reclamante, senza proporre uno specifico motivo di censura avverso la relativa quantificazione, si è limitata, in sede di reclamo, ad invocare la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.”
Il ricorso è dunque rigettato.
L’amministratore revocato, che si è avventurato verso la solenne batosta in sede di legittimità, oltre alle due dei gradi di merito, è un avvocato che si è difeso in prima persona.
© massimo ginesi 12 dicembre 2017